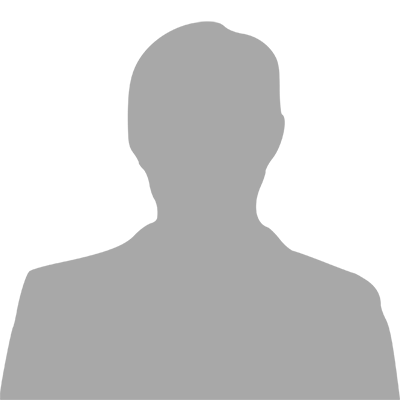Presentazione libro “I confini del mondo magico – Per una antropologia della Janara”
Descrizione
Due illustri ricercatori e antropologi Mario De Tommasi e Maria Scarinzi hanno scritto a quattro mani un saggio dal titolo “I confini del mondo magico – Per una antropologia della Janara”. Ideas Edizioni. Una ricerca approfondita di ben 230 pagine che consegnano ai lettori per approfondire, capire e tuffarsi nel misterioso e magico mondo delle Janare. Il 19 agosto alle ore 18:00 presso l’Archeoclub di Pietrelcina palazzo De Tommasi – Bozzi in via Riella è prevista la presentazione dell’importante pubblicazione dei due scrittori – ricercatori. Un evento molto atteso dalla collettività per l’importante tematica trattata e approfondita con bravura e maestrìa dal duo De Tommasi – Scarinzi autentici antropologi. Autori della prestigiosa e approfondita tematica trattata nell’intero libro.
Sono previsti i saluti dell’assessore alla Cultura di Pietrelcina Domenico Rossi, come pure del presidente dell’Archeoclub di Pietrelcina Paolo Tresca. A seguire, gli interventi dei due autori dell’importante saggio – ricerca Mario De Tommasi e Maria Scarinzi.
A moderare l’intera serata culturale Lino Santillo.
“I confini del mondo magico – Per una antropologia della Janara – dichiarano Mario De Tommasi e Maria Scarinzi – non vuole essere un libro storico né tantomeno indagare le origini di una figura, quella appunto della Janara, la strega beneventana, che trova i suoi natali in un tempo e in uno spazio difficili da esplorare in quanto la vedono fondersi e confondersi con lo stratificarsi del tempo.
Con questo saggio si cercherà di dare voce a tutti quegli attori sociali che hanno reso la nostra provincia un luogo in cui le donne hanno contribuito a scrivere pagine importanti del libro di una storia comune fatta di una miriade di narrazioni. Si tratta di un lavoro che mira a restituire una fotografia il più fedele possibile della cultura indagata, pur nella consapevolezza che le sfumature che attraversano il territorio di ricerca sono innumerevoli e volerle riprodurre tutte sarebbe un’impresa titanica. Sarebbe come voler afferrare l’inafferrabilità della Janara riuscendo a bloccare il vento in un pugno”.
Una antropologia della Janara si riferisce allo studio, attraverso la lente dell’antropologia, della figura della Janara, una strega del folklore campano, in particolare della zona di Benevento. Questo approccio analizza le Janare non solo come personaggi di leggende, ma come elementi culturali che riflettono credenze, paure, e pratiche sociali di una determinata comunità.
L’antropologia della Janara esplora diversi aspetti.
Il termine “Janara” deriva probabilmente da “Dianara”, seguace della dea Diana, o da “Ianua”, che significa porta, e si riferisce alla credenza che le Janare potessero entrare nelle case attraverso le porte.
Le Janare, nel folklore, sono spesso descritte come donne che possiedono conoscenze di erbe medicinali e pratiche magiche, talvolta utilizzate per curare, ma anche per malefici.
Le Janare sono associate a luoghi specifici come il Noce di Benevento, dove si diceva che si radunassero per i loro sabba. Il loro mito si intreccia con pratiche pagane e credenze legate alla natura e alla magia.
Il sabba delle Janare è un termine che si riferisce agli incontri notturni che, secondo la leggenda popolare, le streghe (Janare) di Benevento tenevano, solitamente sotto un noce lungo il fiume Sabato, per celebrare riti magici e misteriosi. Questi raduni erano spesso associati a figure demoniache, come il diavolo o animali come caproni o cani, e a pratiche rituali che includevano danze, canti e riti orgiastici.
Le Janare sono streghe della tradizione beneventana, figure femminili dotate di poteri magici, spesso descritte come malvagie e capaci di compiere malefici.
Il termine “sabba” indica l’incontro notturno delle Janare, dove si supponeva che celebrassero riti magici e si unissero a entità demoniache.
Il luogo tradizionale per il sabba delle Janare era sotto un noce, spesso identificato con quello che si trovava lungo il fiume Sabato, dove si diceva che le streghe si riunissero.
I riti del sabba includevano danze, canti, e pratiche rituali che, secondo le leggende, erano associate al culto del diavolo o a figure animalesche come caproni o cani, e che potevano avere connotazioni orgiastiche.
Si credeva che il sabba avesse lo scopo di rafforzare i poteri magici delle Janare, consentire loro di compiere malefici e di entrare in contatto con forze demoniache.
Per proteggersi dalle Janare, si usava lasciare una scopa o del sale davanti alla porta, poiché si credeva che le streghe fossero costrette a contarne i fili o i grani prima di poter entrare.
L’antropologia studia come il mito della Janara si è evoluto nel tempo, passando da figure di guaritrici a streghe temute, e come il mito influenza ancora oggi le credenze popolari e le rappresentazioni artistiche.
L’antropologia della Janara aiuta a comprendere come la stregoneria, nella cultura popolare, sia un fenomeno complesso, legato a paure, superstizioni, ma anche a conoscenze e pratiche specifiche di una determinata area.
In sintesi, l’antropologia della Janara è un campo di studio che utilizza gli strumenti dell’antropologia per indagare il significato culturale e sociale della figura della Janara, analizzando le sue origini, le sue funzioni, e il suo impatto sulla cultura popolare di Benevento e della Campania.